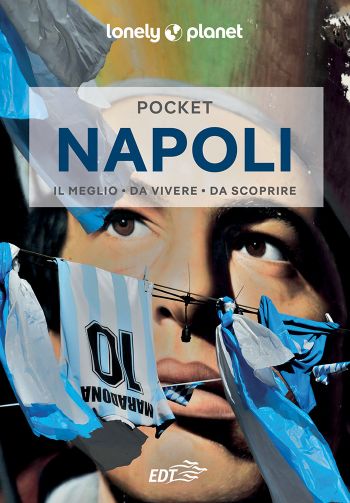Tutti i segreti della cappella Sansevero, a Napoli, tra arte e alchimia
Tra i decumani della Napoli vecchia, in quello che fu il quartiere degli alessandrini d'Egitto, si nasconde un luogo che ha suscitato curiosità e mistero. Nella cappella Sansevero alchimia e religione si incontrano rendendo l'edificio e i tesori che racchiude, in particolare il Cristo Velato, uno dei posti più magici della città della Sirena.

Un amore infedele
Tra le tante leggende che ruotano attorno alla fondazione della piccola cappella, conosciuta a Napoli come Santa Maria della Pietà o Pietatella, con non poche difficoltà si è fatta spazio l’idea, accreditata tra gli studiosi, che sia stata costruita conseguentemente a una storia d’amore finita in tragedia.
Una mattina d’autunno del 1590, il principe Carlo Gesualdo da Venosa comunica alla moglie e cugina Maria d’Avalos che si sarebbe recato fuori città per qualche giorno per una battuta di caccia. Maria sfrutta l’occasione per invitare a casa sua il duca d’Andria, Fabrizio Carafa, suo amante. Carlo, a conoscenza della relazione, in realtà rimane tutto il giorno a Napoli e quella notte entra in casa sua, trova i due e, con coltelli e spade, porta a termine la sua vendetta.

La triste fine dei due amanti porta la madre di Fabrizio, Adriana Carafa della Spina nonché prima principessa di Sansevero e la pia moglie Maria Maddalena a far edificare la cappella per salvare l’anima del defunto dall’adulterio commesso.
Viene eretta così, a pochi passi da piazza San Domenico Maggiore, questa piccola cappella. Un ex-voto voluto dalla principessa di Sansevero.
Ma è solo a metà del settecento con Raimondo che il luogo diventa ciò che conosciamo oggi.
Leggi anche:
Napoli esoterica: la storia di Raimondo di Sangro
Raimondo di Sangro, VII principe di Sansevero, è uno scienziato che ha devoluto la sua vita a numerose discipline, tra le quali primeggia l’alchimia. Entrare nella cappella vuol dire entrare nel suo mondo, fatto di simbolismo e di riferimenti al contesto massonico di cui lui ne era stato Gran Maestro per un periodo.
A partire dagli anni ’40 del settecento don Raimondo inizia ad abbellire la cappella con statue fatte scolpire da grandi maestri dell’epoca, produce i colori che verranno poi usati per decorare la volta, la Gloria del Paradiso, e trova ingegnosi metodi per realizzare la pavimentazione.
Nel suo laboratorio fa esperimenti, costruisce macchinari, alimentando così macabre leggende sul suo conto. I suoi studi sull’anatomia lo portano ad assumere l’anatomopatologo siciliano, Giuseppe Salerno, incaricato di costruire, con l’uso della cera d’api e di altri materiali, due figure antropomorfe a grandezza naturale che mostrano il sistema cardiocircolatorio umano. Le macchine anatomiche, secondo una diceria, sarebbero state create utilizzando come cavie una coppia di domestici, uccisi per poi iniettare nel loro sangue un liquido di loro invenzione a base di mercurio che avrebbe “metallizzato” vene e arterie.
Quanto la scienza per la Napoli del settecento fosse distante dalla vita quotidiana, lo si può dedurre proprio dalle cupe storie che avevano circondato la vita dello scienziato. Fatto sta che ancor oggi, le due figure che si possono vedere nella Cavea sotterranea della cappella, rimangono le opere più misteriose e tetre del luogo.
Prenota un hotel su Booking:

Iscriviti alla nostra newsletter! Per te ogni settimana consigli di viaggio, offerte speciali, storie dal mondo e il 30% di sconto sul tuo primo ordine.
Museo Cappella Sansevero: la cappella e le opere
Nell’entrare nella cappella si rimane subito ammagliati dalla bellezza di quella che è la scultura più famosa di Napoli, il Cristo Velato.
La scultura realizzata da Giuseppe Sanmartino rappresenta il corpo esanime del Gesù coperto da un sudario. I convulsi ritmi delle pieghe del velo incidono una sofferenza profonda, quasi che la pietosa copertura rendesse ancor più nude ed esposte le povere membra, ancor più inesorabili e precise le linee del corpo martoriato. Quel velo, insieme ad altre opere presenti nella cappella, ha suscitato non poco stupore, tanto da far credere a molti che fosse stato realizzato dal principe Riàvulo, principe diavolo (soprannome datogli dai suoi contemporanei), attraverso un processo alchemico di marmorizzazione di un vero tessuto. Stupisce forse maggiormente il sapere che non c’è nessuna magia o diavoleria nella realizzazione dell’opera marmorea, se non l’incommensurabile maestria dell’artista.
“Darei dieci anni di vita pur di essere l’autore del Cristo Velato”, sembrerebbe aver detto Antonio Canova trovandosi davanti al capolavoro del Sanmartino.
Non lasciatevi stregare solo dal sua magnetismo. Ogni scultura del luogo offre, a chi sa dove guardare, continui riferimenti tra cristianesimo, alchimia e massoneria. Un continuo gioco al vedere al di là di ciò che è visibile. Il modo singolare di Raimondo per rendere tutti contenti, soprattutto la Chiesa dell’epoca così poco accondiscendente verso culti e pratiche pagane.

Napoli, la Cappella Sansevero oggi
Ad oltre quattrocento anni dalla sua fondazione la cappella rimane uno dei luoghi più affascinanti e misteriosi della Napoli odierna. Gli attuali proprietari, discendenti di Raimondo, si sono adoperati per farla conoscere al mondo e per cercare di sfatare qualche vecchia leggenda. Visitare la cappella oggi può essere un’impresa, vista la sua notorietà, conviene prenotare una visita. L’utilissima audio-guida realizzata ad arte dal museo vi aiuterà a districarvi tra statue e simboli. Se la storia dei Sansevero vi incuriosisce, potete approfondire con uno dei libri che Martin Rua, scrittore che ha collaborato col museo, ha dedicato al tema.