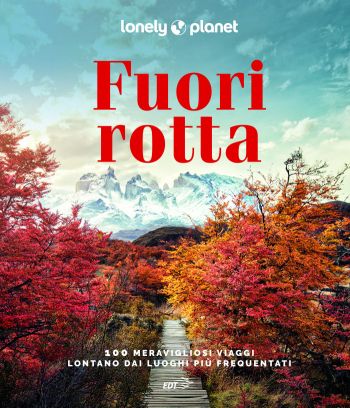Algeri la “bianca”, una casbah tra il deserto e il mare
Il Café Malakof ha un carisma fané che viene confermato anche dalla fisionomia dei suoi clienti abituali: gente delle classi basse, perlopiù anziani, patiti del Domino e delle chiacchiere da bar. È un ritrovo iconico nella Bassa Casbah, un luogo pieno di ricordi e di storie della vecchia Algeri, che ha visto sfilare nomi leggendari della musica chaâbi. Il suo ultimo proprietario è stato El Hadj Mhamham El Alka, alias Le Cardinal, lui stesso cantante. A fine anni novanta stava cadendo in rovina. Chiuso per diversi mesi, è poi stato riaperto nel 2001.

La ristrutturazione è servita solo a dare una rinfrescata, ma il locale ha conservato la sua anima d’altri tempi. Foto di ex cantanti e musicisti chaâbi adornano le pareti, strumenti musicali e antichi utensili di rame continuano a raccontare la storia della vecchia medina, quadri che rappresentano velieri ribadiscono il legame col mare. Tè alla menta o caffè ristretto, biscotti al miele o frittelle al sesamo: è bello sedersi al Café Malakoff per un vero e proprio tuffo nel passato.

Caffè e moschee che circondano una piazza
Ecco, un attraversamento del centro di Algeri potrebbe anche iniziare da qui. Il Malakoff è piazzato in una via un po’ nascosta, Rue du Vieux Palais, ma nevralgica. Con le spalle al mare, la casbah che gli preme addosso e la magnifica Djamaa Ketchaoua, a pochi passi. “Ketchaoua” in berbero vuol dire “piatto di formaggio di capra”, è una moschea che fronteggia Place Ibn Badis e che è stata eretta nel 1436, poi ingrandita nel 1792, trasformata in cattedrale dai francesi nel 1832 e riconvertita in moschea dopo la guerra di liberazione. La cosa che colpisce di più entrando oggi in questo tempio islamico sono la scala esterna (davvero poco usuale per una moschea) e le gigantesche iscrizioni di frasi del Corano che ne ornano le pareti all’interno insieme alle antiche decorazioni bizantine. A questo punto si può “scartare” fino a Place de Martyrs, un gigantesco spiazzo moderno incuneato tra i bastioni del passato, le tre moschee in primis (la Djamaa Ketchaoua, la Djemaa El Djedid e la Mosquée Ali Betchine), i tanti musei (Museo delle Arti e Tradizioni Popolari, Museo del Patromonio Culturale, Centro Nazionale delle Richerche Archeologiche) e il vecchio Marché Randon, un mercatino disastrato ma interessante.

Se vi trovate sulla piazza all’ora di pranzo, scivolate fino al Barberousse, un posto nascosto e molto essenziale, come il Malakoff, dove mangiare il pescato del porto (d’altronde è piazzato nella Rampe de la Pēcherie) e una zuppa di verdure (con o senza cous cous) gustosissima, spendendo pochi dinari algerini. Il caffè, soprattutto se vi piacciono le esperienze molto informali, potete gustarvelo poche centinaia di metri più in là, sempre sul lungomare, nel piccolo Bar Terminus annesso all’Hotel omonimo. Hotel glorioso in preda a un perenne sfacelo, come il bar attaccato, che il più noto scrittore algerino contemporaneo, Aziz Chouaki, tira in ballo più volte nel suo romanzo La stella d’Algeri: “ritrovo di tiratardi e di insonni, di musicisti, di marinai, di piccoli malavitosi, di ballerine e di prostitute”. Chouaki lo compara anche a un altro storico ritrovo (più notturno che diurno): il Café Tantonville (vicino al vecchio Teatro dell’Opera, in Place de la République).

Iscriviti alla nostra newsletter! Per te ogni settimana consigli di viaggio, offerte speciali, storie dal mondo e il 30% di sconto sul tuo primo ordine.
Il teatro urbano del centro, retaggio coloniale e arena del popolo
In questa sorta di rimpiattino sulla riva di una città appoggiata al mare, che scopre spesso anche lo sperone possente su cui è stata costruita l’ottocentesca Basilica di Nostra Signora d’Africa, la più importante chiesa cristiana di Algeri, possiamo passeggiare fino al fulcro del quartiere francese della capitale, ovvero la Grande Poste d’Alger e le Jardin de l’Horloge Fleurie. Prima però c’è da attraversare la piazza dedicata all’emiro Abd el Kader, ribelle e combattente per l’indipendenza dalla Francia, ricordato con una bella statua equestre; all’angolo il Milk Bar, tristemente famoso per una serie di attentati da parte dei terroristi islamici negli anni novanta e preso di mira anche nella lotta degli anni cinquanta e sessanta contro la potenza coloniale (è il bar dove Pontecorvo nel suo imperdibile ritratto de La battaglia di Algeri fa entrare la donna con una bomba nella borsetta).
Due passi nelle vie eleganti, Rue Didouche Mourad e Rue de la Marine, fino alla Grande Poste, edificio in stile neo moresco costruito nel 1910 che è davvero l’ufficio delle poste, ma è oramai anche molto altro. Sta nel crocevia noto come Grande Poste (ex Plateau des Glières), all’incrocio degli assi principali del centro di Algeri: le rampe di Tafourah a Est, che consentono l’accesso dal porto; rue Larbi Ben M’Hidi, a Nord, che conduce allo storico quartiere della Casbah; boulevard Mohamed Khémisiti (precedentemente Laferrière), a Ovest, che abbraccia il Giardino dell’orologio floreale prima di salire sull’Esplanade d’Afrique che si affaccia sul Palazzo del Governo; mentre a Sud ci sono Emir El Khettabi Avenue e le altre arterie commerciali della città. Sono luoghi che non arrivano a restituire la memoria emozionale della vicina casbah, ma dove oramai pulsa il termometro umorale della gente di Algeri e dove, anche recentemente (ogni venerdì e martedì dal febbraio 2019), si radunano decine di migliaia di persone per reclamare pacificamente le proprie istanze.

Tre spazi che si guardano tra loro: Giardino botanico, monumento ai caduti e museo nazionale
In fondo è semplice capire la planimetria di Algeri. Costruita su una baia - come Genova, come Marsiglia - si erge per accogliere i suoi tre milioni e mezzo di abitanti.
Semplice fino a un certo punto. Indispettita dall’aver scelto il nome di quattro isole che aveva davanti almeno fino al 1525 (il nome che deriva dall’arabo al-Jazā’ir, vuol dire appunto isole) e che ora non ci sono più, inglobate dalla terraferma, ha poi finito per esondare nell’entroterra fino al deserto che la lambisce, coprendo un perimetro irto di saliscendi, di veri e propri altopiani che, alle volte nascosti l’uno all’altro, ricordano Rio De Janeiro. Metteteci anche che i responsabili della viabilità hanno deciso di ignorare l’invenzione del semaforo (secondo molti taxisti il centro ne è quasi completamente sprovvisto) e il caos è fatto.
Una bella eccezione a questa regola topografica è il gigantesco giardino botanico. Il Jardin Botanique du Hamma occupa una bella porzione di lungomare con un incredibile, ancorché poco curata, collezione di percorsi alberati (palme, bambù, enormi platani e ficus), giardini, ruscelli, canali, prati e radure. Nel punto dove l’intreccio di alberi e piante si lascia sconfiggere da un vialone e da uno spiazzo si ha un punto di vista privilegiato sul monumento ai caduti che domina il lungomare da un colle.

È il Memoriale dei Martiri, Maqam Echahid, eretto nel 1982 in occasione del ventennale di indipendenza dell’Algeria. Noto anche come “Tour Eiffel algerina” (è una torre sottile alta 92 metri) e come ‘Fiamma eterna’, poiché alla sua base è posizionata una grande fiamma perennemente accesa. Il sito comprende, oltre al monumento, anche un anfiteatro, una cripta, il Museo El Mujahid e il Museo delle armi della città.
Dallo stesso colle potete raggiungere il Museo nazionale delle Belle Arti, il più grande museo dell’Africa e del Medio Oriente, che custodisce anche una preziosa sezione dedicata agli orientalisti, oltre a una collezione di pregevoli pittori algerini. Non mancano naturalmente, i maestri francesi: Gauguin, Renoir, Monet e Degas. Da qui, anche per vedere lo stesso panorama da una doppia prospettiva, potrete concentrare lo sguardo sul giardino botanico e apprezzarne in un colpo solo i venti ettari di estensione e la sua grande mappatura, che inevitabilmente, attraversandolo a piedi, un poco sfugge.

Lo scrigno prezioso e pulsante della casbah
La casbah di Algeri è un antico quartiere fondato sulle rovine della vecchia Icosium. Una città dentro la città, costruita su una collina che scende verso il mare. La casbah è divisa in due piccoli quartieri: la città alta e la città bassa. Detta così sembra in fondo poca cosa. E invece la casbah è un posto di una bellezza allibente, ancorché bisognoso di recuperi, restauri e manutenzione che spesso latita. Eppure non mancano gli squarci sontuosi di palazzi nobiliari (imperdibili Dar Aziza, Dar Mustapha Pacha, Dar Khedaoudj El Amia e Le Palais du Rais), madrase, moschee, hammam e perfino cimiteri, quasi tutti da scoprire all’improvviso, varcando una soglia.

Su tutto domina però lo spettacolare e intricatissimo ordito di abitazioni in calce bianca e viuzze zigzaganti. È in questo mosaico dadaista che si dipana la vita pulsante del popolo che ancora la attraversa e che è stata una componente fondamentale nell’assegnazione del titolo di Patrimonio Unesco. Quasi diciotto ettari di estensione, cinquantamila persone ad abitarla. Dal punto di vista logistico, il quartiere è inespugnabile. Si estende sul pendio di una collina dalla cima al mare e le strade, tutte in saliscendi, sono strettissime, a scalini ineguali, tortuose, spesso prive di uscita. Nessun mezzo meccanico vi può passare (e infatti per portar via le immondizie si utilizzano i muli); le case sono state costruite senza un piano regolatore, le loro sommità spesso si toccano cosi da formare un imbuto, le pareti sghembe, le finestre sulla strada sono rare, piccole e con le grate. La vita familiare, quanto mai riservata, si svolge all’interno, spesso in un cortile; talvolta gli edifici sono uniti da un corridoio coperto che passa sulla strada, formando una galleria.

Fu nella casbah che si preparò la riscossa contro la potenza coloniale. Dopo lo scoppio della rivolta (il 1° novembre 1954), i capi nazionalisti si installarono qui per dirigere le operazioni e qui ripararono i combattenti del FLN inseguiti dai Francesi e nonostante le retate, li sconfissero. Usarono le case della casbah come “sottomarini” e come “bunker”. Nella casbah vi sono due tipi di case moresche: la casa propriamente detta ed-dar e la dwéra, piccola costruzione annessa alla prima e talvolta indipendente. La prima, quando è vasta e ben costruita, può sembrare un vero palazzo: le corti sono ornate da piastrelle di maiolica a colori diversi, e molte hanno il loro pozzo e la loro cisterna. Sono costruite con i materiali che abbondano nei dintorni di Algeri: il tufo per le fondamenta, i mattoni cotti al sole per i muri, o le pietre che provengono dalle rovine romane della regione, il legno tagliato nelle foreste delle più vicine montagne.
Per visitare la casbah c’è chi consiglia di partire dal quartiere che la sovrasta, la Cittadelle, e poi scendere verso il mare (anche per fare meno fatica nelle viuzze scoscese) e chi preferisce partire dal basso per inaugurare una sorta di stupefacente e lenta scalata piena di sorprese. Date retta a noi: la casbah fatela in tutte e due i sensi. E poi ricominciate da capo.