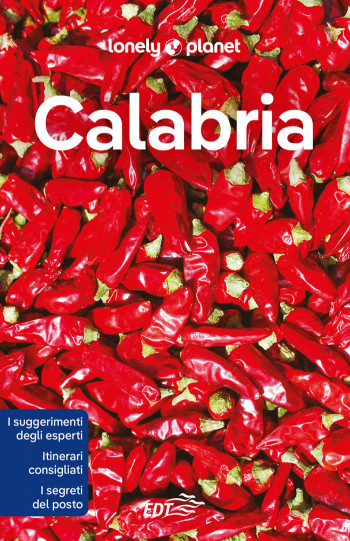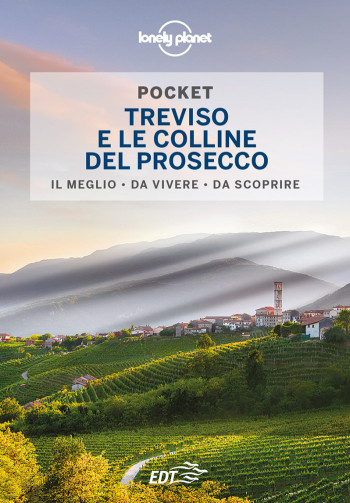Nonostante secoli interi di abbandono, il tempo e le avversità non sono riusciti a scalfire la solenne magnificenza di Paestum. Come un frammento di classicità incastonato nella Campania, la città fondata dai coloni greci di Sibari nel VII secolo a.C. lascia a bocca aperta i visitatori oggi non meno di 2500 anni fa, quando mercanti, navigatori e poeti decantavano l’opulento splendore dei suoi edifici. La maestà dei tre templi principali, infatti, è rimasta intatta, le tracce della colonia latina fondata a partire dal 273 a.C. arricchiscono di ulteriori suggestioni, i soavi roseti che fioriscono due volte l’anno, già celebrati da Virgilio e Marziale, adornano le sublimi architetture di cromie bucoliche. Per tutte queste ragioni, Paestum è uno dei siti archeologici più affascinanti della penisola. Dopo i fasti romani, il declino iniziò con la caduta dell’impero e il progressivo allontanarsi dalla costa delle popolazioni, a causa delle incursioni saracene e delle epidemie di malaria. La riscoperta avvenne nel Settecento e all’epoca del Grand Tour si impose tra le testimonianze più fulgide della grandezza antica. Grazie soprattutto alle campagne di scavi del secolo scorso, da vedere c’è anche il ricco museo.
Il parco Archeologico di Paestum
La visita è ovviamente imprescindibile se si arriva al sito: si inizia dal Tempio di Cerere (in realtà dedicato alla dea Atena), tipicamente dorico e risalente alla fine del VI secolo a.C. In un ipotetico itinerario in direzione sud, dopo aver attraversato i resti delle antiche abitazioni, ecco sulla sinistra l’anfiteatro romano (I secolo d.C.), parzialmente sepolto dalla strada moderna. Poi, s’incontra il foro: orientandosi con i basamenti delle colonne, non ci vuole molta fantasia a immaginarlo brulicante di vita in età romana, con il porticato su tre lati, le botteghe, gli odori acri provenienti dal Macellum sul lato sud, l’aura di spiritualità che avvolgeva il Tempio di Mens Bona, sul lato nord. A quel punto, sarete pronti per raggiungere l’apice estetico della vostra esplorazione con il Tempio di Nettuno o Poseidone, dedicato al dio del mare a cui i greci consacrarono l’intera città (il suo nome originario era Poseidonia). Si tratta del più straordinario risultato dello stile dorico in Italia, con i due ordini di colonne (sei sul lato della facciata, 14 sul lato lungo) poggiate sul basamento, le metope e i triglifi che sovrastano il possente architrave, l’austero pronao che introduce lo spazio interno.